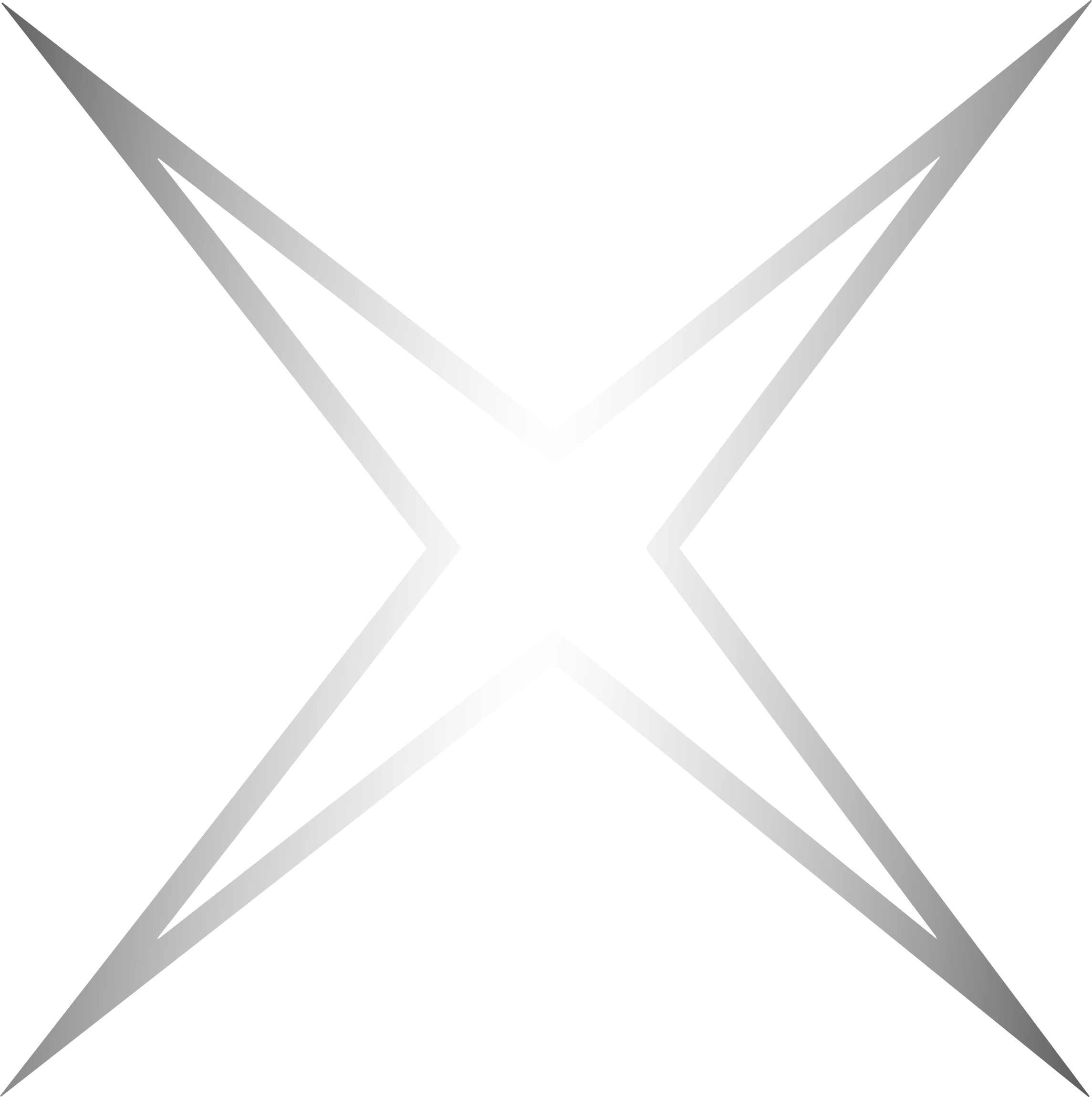inter
Nuvola
4 febbraio
Nuvola Ravera,
Genova, 1984, è un’artista contemporanea che opera in dialogo
con esperti in vari campi nel corso della
produzione delle sue opere, le quali hanno una qualità sempre mutevole, sia per la loro
materialità effimera che per le forme linguistiche che sono profondamente collegate
ai
luoghi in cui lavora.
MM:
Non ti fermi spesso e a lungo in un luogo, citando il tuo stesso testo per The
statues have escaped, sei in fuga? E per dove e da cosa?
NR:
Sono tornata a Genova da meno di un anno. Ho lasciato ufficialmente Venezia quest’estate. Dopo i tanti spostamenti per lavoro e studio, ho dovuto come molti rallentare e farmi più stanziale. E’ stata una scelta obbligata che ha portato grande inquietudine ma anche momenti di concentrazione e approfondimento inediti. In un periodo di obbligo alla staticità, la città che ho a disposizione cambia proporzione a livello percettivo come quando sei bambina e uno spostamento minimo è un viaggio.
Certo è che con l’impianto mobile e febbrile che avevamo nella società smart e low cost, è una dura prova tornare quasi ad un tempo premoderno in cui viaggiare era un privilegio di pochi.
Quindi la voglia di cambiare scenario e complici quotidiani rimane sempre forte.
MM:
Dove andresti?
NR:
Ci sarebbero molti posti che mi piacerebbe vivere e non visitare. In fondo tengo a creare dei riti quotidiani, costruire delle abitudini temporanee legate al contesto per conoscerne almeno parzialmente alcuni elementi costitutivi.
Ogni luogo in cui sono stata è diventato molto familiare, qualcosa da considerare presto casa. Ci sono dei posti che mi interessano dal punto di vista esperienziale, culturale, e altri che sono invece preziosi dal punto di vista funzionale per lavorare o accedere a dei contenuti o dei servizi. Molto spesso le due cose non coincidono. La complessità che mi interessa dal punto di vista sociale, urbanistico e culturale la ritrovo spesso in luoghi caldi, in certi sud dove la temperatura è sia ambientale che caratteriale. Probabilmente è una forma di esotismo che ho sviluppato nell’infanzia frequentando molti viaggiatori di svariate culture. Ma ora diciamo che andrebbe bene qualsiasi luogo, sia il freddo e organizzato nord Europa per lavorare o anche un nord Africa per fare ricerca o
semplicemente vivere un’altra terra.
MM:
Hai studiato Pittura all'Accademia di Genova, poi Fotografia alla Bauer a Milano e Cinema Video a Brera, dopo di che ti sei spostata a Venezia dove hai intrapreso una residenza alla
Bevilacqua la Masa e hai completato la tua tesi di ricerca allo IUAV di Venezia. Sono curiosa di
avere da te un racconto sul tuo viaggio formativo. In che modo poi quello che hai appreso nelle varie tappe
ha contribuito in quella che è la tua pratica in divenire?
NR:
Ho affrontato così tante discipline perché in realtà ogni metodo didattico incontrato mi appesantiva profondamente. Molti linguaggi mi sembravano limitanti in un perimetro costrittivo in cui non riuscivo a restare a lungo: i virtuosismi tecnici propri delle scuole d’arte mi annoiavano.
La prima tappa all'accademia è stata una scelta/non scelta. Provenivo da un liceo artistico che era spesso un luogo di sfogo e contenimento per ragazzi che non si inserivano bene in quasi nessun altro contesto più normativo.
Quando ho concluso il liceo avevo la sensazione di non avere imparato nulla. Passai quegli anni a vigilare sui miei compagni dipendenti da sostanze e nutrirmi di cinema. La scuola si trovava a Quarto davanti alla sede dell’ex ospedale psichiatrico provinciale,
ospite di uffici sanitari e asl sempre nel campo dell’accoglienza psichiatrica. Invece di andare a lezione passavamo molte giornate là dentro. E’ curioso che poi negli anni successivi abbia sviluppato questo grande interesse per le pratiche così dette “PSI” riguardanti la salute psichica. Capisco solo ultimamente quanto la frequentazione assidua di questa istituzione di cura possa aver influenzato tra le altre cose le mie traiettorie future.
Più tardi mi sono iscritta all'Accademia perché mi sembrava non potessi fare altro. Non avevo una passione per la pittura in particolare ma era l’unico filtro attraverso cui eravamo stati (mal)formati. Ritengo di avere passato 3 anni a imparare ciò che non avrei voluto fare, le cattive pratiche. La maggior parte degli insegnanti boicottavano le mostre e l’arte contemporanea era un lontano spiraglio studiato su qualche raro testo consigliato in qualche raro corso teorico. Passavamo il tempo a dipingere nature morte in stile Morandi e al massimo corpi nudi che vagamente ricordavano Lucian Freud e nella più radicale delle occasioni Francis Bacon. Dalla frustrazione provata in quell'ambiente accademico, a causa della mancanza di scambio critico, la ricerca che non si sviluppava perché non eravamo chiamati a farlo ma anzi a sottostare a regole formali, cominciai a fotografare perché mi sentivo più libera nell’esplorazione del mondo intorno.
Ho pensato così di approfondire il discorso fotografico a Milano, anche per cambiare contesto culturale. Ma devo dire che ho sempre navigato in questo senso di costrizione e non sopportazione dei contesti istituzionali e accademici. Anche a Milano non ho sentito terreno fertile nella struttura formativa. In seguito Brera mi ha permesso di incontrare delle figure critiche interessanti e di intraprendere un dialogo sulla forma di attivismo dell’arte e la possibilità di usare l’arte collettivamente. Più tardi, durante un internship nello studio di Armin Linke, ho capito che il mondo
della fotografia contemporanea non volevo mi appartenesse come unico linguaggio per la mia pratica artistica, ma piuttosto come strumento di lavoro e collaborazione di servizio nei confronti di gallerie, musei e artisti, prestando il mio sguardo documentativo ad altri. Questo mi ha permesso di continuare a sviluppare una ricerca personale che non necessariamente si appoggiasse sul visivo o sui linguaggi già consolidati delle belle arti. Più che imparare una tecnica, in questo percorso disfunzionale ho cercato di sviluppare una pratica, che non si appoggiasse e non si proteggesse nella comodità di una modalità linguistica ma che aprisse il campo percettivo e discutesse questioni sociali con strumenti sempre diversi.
Per quanto abbia sempre rincorso strutture formative, provengo da una famiglia anarchica che non aveva la volontà di scolarizzarmi. Questa impronta familiare mi ha sempre messo in una condizione di critica e spesso anche disagio perché mi ha comunque stimolato a essere sopra le righe e in contrasto con le norme e le discipline. Ero sempre più punk del dovuto e parecchio critica sulle modalità didattiche. Senz’altro è questa una delle ragioni per cui c'è sempre stata l'esigenza di cambiare contesti e linguaggi. I miei genitori erano nomadi, facevano i lavori stagionali e giravano
per la Spagna, la Francia, l'Italia, cambiando spesso case, comunità e paesi. Per quanto sia stata poi scolarizzata e imborghesita dal nucleo familiare dei miei nonni, è come se avessi sempre mantenuto una sorta di impronta primaria che non mi ha mai permesso di far pace con l'istituzione. In ultimo mi sono iscritta allo Iuav decidendo finalmente che avrei fatto attraverso di esso un'autoformazione, usando un contesto accademico per arrivare a discutere delle questioni che veramente mi premevano. Qui avendo anche un’età superiore, pur sempre nell’indisciplinatezza, mi è stato permesso di trovare delle strutture di progettazione, degli strumenti teorici e dei metodi per aggiustarmi finalmente addosso un vestito più simile alla mia taglia.
MM:
Come trovi che le tue produzioni si siano evolute nel tuo percorso fino ad'ora?
NR:
Nei miei primi lavori c'è stata certamente una necessità personale all’autoanalisi. Erano lavori più intimi in cui la ricerca si basava su un tentativo di posizionamento del sé nei confronti del mondo. Lentamente e naturalmente ho iniziato a uscire dall’autobiografia per indagare sistemi di relazione collettivi, modalità culturali e schemi sociali appartenenti a diversi contesti.
Lo spazio e i luoghi hanno iniziato ad acquisire la forma di personalità vive da incontrare nel mio lavoro. I modi in cui la società ci vuole considerare fragili, malati o in salute, sono diventati delle forme scultoree, delle configurazioni installative, dei ricordi visivi di memorie non vissute ma presenti.
Il valore dei nostri artefatti e dei nostri beni, come li proteggiamo e conserviamo ossessivamente è diventato un perimetro di indagine per capire anche l’uso dei nostri corpi, il significato dell’igiene fisica e psichica, la forma e la texture delle nostre vite estetiche e relazionali. Da qui ho iniziato a comporre dei lavori effimeri la cui presenza come forme pensiero e soggetti in trasformazione però durano per anni.
MM:
Mi racconti del processo/processi con cui arrivi alla formalizzazione del tuo lavoro?
NR:
Brancolando nel buio!
Dice Wislawa Szymborska durante un discorso pubblico che l’ispirazione, qualunque cosa sia, nasce da un incessante non so. Sono d’accordo con lei, e con le sue “parole alate” – non so-. Come se fossi un esploratore che non sa dove sta andando, non sa esattamente a cosa vuole arrivare ma sente di doversi spostare, di dover andare nell’incertezza. Finché non ci arriva non sa che è arrivato. Credo di seguire un processo istintivo e senza metodi ricorrenti.
Sicuramente ci sono degli elementi ricorsivi, come ad esempio quello onirico.
L’attenzione alla materia del sogno è parte della mia pratica da quando ho ricordo, segno tutto quello che accade nel sonno. Uno dei primi lavori che ho esposto era proprio basato su una serie di allucinazioni pre-sonno: Pink elephant. In quel caso il processo era stato la trascrizione nel dormiveglia di allucinazioni ipnagogiche per arrivare a una loro realizzazione attraverso varie espressioni formali. Però non è un processo che ripeto. Sicuramente ricorre un lavoro di autocoscienza. Ho sempre inteso la pratica artistica come un grande lavoro psichico e di elaborazione. Quella del residuo psichico è una delle questioni che mi ossessiona in ogni lavoro, che cosa c’è di noi oltre il visibile, delle forme che abitano il mondo, quale inconscio residuale rimane degli oggetti, delle persone, degli ambienti – passati, presenti e futuri. Se vogliamo questo è lo scheletro base di ogni formalizzazione con il quale mi relaziono tutt’oggi.
Si possono considerare i miei lavori come delle lunghe gestazioni in cui parto da delle domande, delle angosce e dei desideri da cui devo poi distanziarmi per superarle e approfondire cosa c’è al di là delle parole, delle narrazioni e delle forme che nominano i fenomeni. Comincio spesso facendo delle letture per trovare dei complici nel pensiero. All'inizio sono pudica e non trovo il coraggio di toccare la materia. Quell’istinto primordiale della me bambina abituata a giocare con delle argille portate dai genitori in delle case diroccate, è stato spesso tradito.
E’ come se mi permettessi solo alla fine di un lungo percorso, la possibilità di toccare e
portare poi fuori e all'altro una formalizzazione.Sono molto lenta a fare le cose materiali, a trovare una restituzione definitiva di un
progetto, ci metto secoli, leggo tremila libri, dormo, sogno, non mi costringo mai a
realizzare o a trovare una soluzione formale. Se non viene non faccio niente. Fare ricerca
mi è stato molto di sostegno perché ho scoperto che il mio pensiero istintivo trovava dei
complici vivi, complici morti, complici pre-platonici. Ci sono alleati che dicono le
cose meglio di noi e che figurano qualcosa che a livello intuitivo si cerca di sviluppare con il lavoro.
MM:
Che cosa vuol dire ricercare per te?
NR:
La ricerca per me è proprio l'idea di non sapere il risultato, cercare delle visioni, delle
intuizioni, astratte o reali, ma le intuizioni non è che le sai.
A volte mi piacerebbe sentirmi confortata dal metodo di un processo ricorrente o da un
linguaggio. A volte questa non processualità ricorrente, il fatto di non avere una forma e
un linguaggio preciso mi fa pensare di essere incoerente, non organica e di non
approfondire mai.
Passando poi per i lavori, che non sono altro che attraversamenti, mi rendo conto che la
coerenza non è nella forma, non è la protezione, ne’ del metodo ne’ del processo ne’ nei materiali. È piuttosto un'articolazione organica tra le cose. Come una cartografia con tanti
punti diversi che sembrano scollegati ma che in realtà fanno parte dello stesso
emisfero. Forse è più caotico e complesso lavorare cosi, è più perturbante, ma ha più a che fare con
un'esplorazione, una crescita, quindi non mi sento di cercare un risultato specifico ma mi è necessario sempre andare avanti, ri-contestare il linguaggio, ri-contestare il lavoro. Fa parte della ricerca ritornare sui propri passi, mettere sempre in discussione il lavoro come se fosse uno strumento per incontrare meglio.
Ricercare è anche rinominare le cose quando hanno bisogno attraverso il rito della nominazione. Soap Opera ad esempio, che ho presentato tre volte, ogni volta è mutato. Una volta è stato solo un pavimento di sapone silenzioso che ricordava un tempo architettonico e pratiche igieniche sovrapposte ad altre, in un altro caso questo pavimento è stato strumento funzionale per una performance di lavaggio e distruzione dell’opera stessa, l’ultima volta è stato installato all'interno di una collettiva per creare un percorso fra le altre opere.
Con la ricerca nascono dei nuovi luoghi, dei nuovi oggetti, li presento e poi li usiamo insieme, e li ridiscutiamo.
Perché non c'è nulla di fisso, la fissità per me è sempre un problema.
MM:
Cambi spesso i titoli alle tue opere?
NR:
Bianca ad esempio ha cambiato forma e nomenclatura mille volte, essendo integrato nella narrazione scritta che ho adottato con la tesi. Prima è stato Bianca, poi Cosmic Latte, poi Bianca è entrato a fare parte di Cosmic Latte che è diventato Clinique e adesso è Bungalow Bunker. Quindi sì, spesso cambio i nomi ai progetti anche se non con tutti i lavori. Quelli che si trasformano di più cambiano anche nome e assetto.
A volte spariscono proprio.
Il titolare è utile per posizionare il lavoro, ma il nominare è un'operazione che in qualche modo battezza l'identità di un lavoro. Magari il battesimo che ho fatto anni fa non è più attuale e non concilia con l’attualità della ricerca.
Gli indiani d'America non attribuivano subito un nome ad un bambino appena
nato, aspettavano che questa nuova vita assumesse una propria personalità, delle sue caratteristiche, così che il nome scelto sarebbe poi stato influenzato dalle caratteristiche identitarie del nuovo individuo. L'esperienza veniva quindi prima del nome.
Bianca e Cosmic Latte sono in questo punto dell’ esistenza in cui si stanno formando.
Ho realizzato delle prime parti di ricerca, ma non ho elaborato il lavoro con una sua restituzione finale, il lavoro deve ancora nascere, quindi anche il nome continua ad essere una materia informe.
MM:
Che cos'è Cosmic Latte e che cos'è Bianca? Immagini che forma che potrebbero
assumere? Che cosa potrebbero diventare?
NR:
Con Cosmic Latte ho deciso di fare un'associazione tra luogo clinico e luogo espositivo. Mi sono chiesta quanto assomigli un White Cube ad un ospedale. Quanto i pazienti vivano esperienze di disagio nelle visite ospedaliere in questi spazi bianchi e disumanizzanti quando vengono trattati come un ingranaggio non funzionale. Parallelamente nell'ambiente espositivo ho sempre ritrovato un aspetto clinicizzante, delle opere e delle relazioni.
Come una comunità scientifica che medicalizza in modo inpersonale, vi è la stessa forma di freddezza nell'ambiente espositivo, che oggettivizza in funzione della mercificazione dell'opera creando un setting il più possibile pulito e asettico per vedere meglio le opere, come i corpi devono essere visti a fondo nella diagnostica.
Le opere così possono emergere come un cristo sull'altare, più facilmente vendibili, senza intrusioni. Ma non c'è vita. C'è questo aspetto mortifero nel White Cube. Creiamo degli scudi protettivi contro il terrore della morte, contro il terrore della malattia,
creiamo delle forme di scudo di protezione, ogni cosa che impariamo è oltre una forma di
comprensione dell'esterno, anche una forma di protezione da quello che possono
essere delle minacce relazionali, minacce sistemiche. Dobbiamo essere sani, forti, efficaci. Questa è il fulcro di Cosmic Latte e Bianca.
Ho camminato negli ospedali vivendoli come musei e viceversa, ho attraversato gli spazi dell’arte come in delle cliniche raccogliendo note. Come una fine di relazione di analisi. Abbiamo fatto un percorso.
MM:
Che cosa volevi da questa relazione e come potevi mettere in discussione il contesto o
la disciplina?
NR:
Dalla relazione di analisi volevo riappacificare le discipline molli con quelle dure.
Intendevo creare dei ponti per avvicinare i contesti, adottare degli scambi di ruolo e prospettiva per integrare le parti migliori del mondo clinico con quelle dell’arte. Bianca era nato come progetto teorico della tesi di ricerca Fake it Until you make it ( 2020) come istituzione fittizia di cura, come idea di clinica a cielo aperto, come culmine di un percorso accademico e di anni di lavori che battevano il ferro sui sistemi
di cura dell’uomo e degli ambienti.
MM:
Qual'è il tuo rapporto con il collezionismo e come ti inserisci in questo sistema?
NR:
Spesso ho venduto le opere da sola. Sono sempre stata autonoma e non ho mai
troppo accettato consigli commerciali o richieste di adesione a uno stile o una modalità per essere più facile.
Ogni tanto mi sono chiesta se ho fatto male o se sarei dovuta essere più malleabile. Infatti è successo che il lavoro sia stato considerato non facilmente vendibile. Per esempio Big Babol, dove c'erano gelatine dalla veloce deperibilità che potevano ammuffire, si è creato questo
problema. Dopotutto però quel lavoro metteva proprio in discussione la durata, il valore,
la figura dell'artista che produce beni materiali, il nostro dover essere materia conservata e immobile. Parte dell’opera era anche mangiabile e l’ho offerta al pubblico in un’ operazione di urbano-fagia delle acque di Venezia.
Non credo di essere molto brava a vendermi, a vendere. Vorrei trovare un modo per rimanere integra ma allo stesso tempo fare del mio lavoro una pratica che può sostentarsi e vivere, crescendo
anche sostenuta da quel contesto, che è spesso però limitante e abbruttente. I mondi dell’arte si prefiggono alti proponimenti, movimenti radicali e poi spesso cadono nelle pratiche sicure e consolidate. Forse tutti i contesti rischiano di organizzare le identità semplificandole e limitandole.
La sfida sta nello stare all'interno dell'istituzione, rispettando il più possibile il proprio lavoro e le proprie posizioni. Le istituzioni permettono al lavoro di arrivare a più persone. Il collezionismo gli permette di essere protetto e valorizzato a volte. Questo non toglie che molte cose radicali possano avvenire altrove e poi essere portate come una memoria e condivisione a un contesto più educato o rigido.
Penso che per i galleristi sia difficile scegliere degli artisti la cui pratica è così volatile. È un rischio commerciale.
Le vie della mia ricerca sono molteplici, incerte e non sempre codificabili. Neanche per me. Emerge spesso una lotta con il lavoro e con il pensiero artistico. Il disagio con l'istituzione ritorna anche qui. Spesso mi ritrovo a dover mediare per presentare
il mio progetto a qualcuno, parlare con i curatori, gallerie. Parlo spesso di questo conflitto
enorme, che è una spinta istintiva e anche naif: il desiderio e al tensione e poi
quest'addomesticamento del lavoro in funzione del poterlo realizzare in un certo
contesto. Quando è quello dell'arte contemporanea è molto faticoso, perchè è
performativo, cerca di imbrigliare, formalizzare in un certo modo per fare in modo di
essere vendibile o socialmente e politicamente connotato, quindi vendibile dal punto di vista etico.
MM:
Trovi che questa difficoltà a dare valore ad oggetti non afferrabili, materici, fisici,
possa essere anche una conseguenza del contesto culturale in cui ci troviamo,
quello italiano?
NR:
Abbiamo certamente un rapporto forte e viscerale col patrimonio e con i beni materiali. É una questione di valore che si dà agli oggetti e a quanto è importante che siano comunque tangibili.
Questo chiaramente crea anche una necessità di avere dei feticci duraturi, qui come altrove ma forse in Italia particolarmente.
Invece credo sia molto più interessante rispetto agli oggetti fatti e finiti assistere al farsi delle ricerche, scoprire i luoghi dove i processi avvengono come quello dell'artista in studio. Sono sempre molto più curiosa di scoprire come un artista lavora, come vive o si comporta nelle scelte quotidiane. Perchè poi i feticci vanno a morire in queste case, in
queste fiere dell'arte, in questi musei. E’ vero che ci giungono artefatti di tutti i tempi ed è un’evocazione magica però spesso nei contesti dell’arte contemporanea la retorica narrativa dei lavori è piatta e superficiale. È un peccato per la ricerca stessa degli artisti. Perché devi inserirti in quei due o tre contenitori dove puoi essere localizzato e usato. Per cui sei rassicurante e vendibile.
MM:
Nei tuoi lavori trovo spesso una certa tensione tra il visibile e il non. Cosa ti porta a
questa tensione?
Se ho ragione nell'individuarla.
NR:
Chiamare molti studi delle arti contemporanee arti visive è fuorviante. Si evoca un unico perimetro percettivo quando esistono tutti gli altri sensi. Sussistono percezioni diverse da parte di individui con abilità e strumenti più disparati nel mondo con capacità e percezioni che non sono solo visive. Mi sembra sensato discutere questa parte rispetto ad un'immaterialità o comunque in
favore degli altri sensi perché alla fine c'è un'egemonia. Il visivo ha sostituito molti tipi di relazioni, scambi e modalità di conoscenza.
MM:
Riguardo l’egemonia dei sensi e l’immateriale, che rapporti hai con un senso invisible come quello olfattivo?
NV:
L’olfatto è uno dei sensi più importanti che abbiamo per incontrare gli altri, lo spazio e gli ambienti. Mi hanno sempre detto che avrei dovuto usare il mio olfatto come mestiere, indifferentemente dal campo specifico del profumo o delle degustazioni. Mia nonna avrebbe voluto farmi studiare alla scuola per nasi a Parigi.
MM:
Hai in mente degli odori che non dimenticheresti mai?
NV:
Se devo pensare a cosa mi rimane più in mente a livello olfattivo c’è un’enciclopedia di voci. Il vento del deserto di Serge Lutens. L’odore dei pneumatici delle carrozzerie insieme al bostic, un tipo di colla. Poi ci sono gli odori che non hanno aroma, sono sensazioni olfattive che prendono tutto il corpo. Quella più ricorrente l’ho sempre chiamata sensazione di cocco. Arriva da quando ho memoria, in alcuni momenti di serenità e vicinanza con le persone, succede d’estate di solito, o nelle stagioni di mezzo. Anche le opere hanno un odore ed è importante riconoscerlo. Infine c’è una sensazione olfattiva che è quella delle note che mi ricordano le persone che ho amato. Qualcosa come legni, speziati, profumi così detti maschili.
MM:
Sapresti individuare l'origine/origini del tuo percorso artistico?
NR:
Un'immagine che compare spesso è questa memoria di quando ero piccola. Avevo dei
mattoncini di creta morbida, non cotta, abitavo in Spagna e mentre i miei genitori
lavoravano io passavo le giornate da sola.
È una figura ricorrente di istintività e rapporto con la materia. Anche riguardo un luogo
ed un contesto, perché immaginavo di fare questi oggetti per degli invisibili. Il rapporto di
invisibilità allora era rispetto ai miei fruitori.
La materia c'era ed era visibile.
Era il gesto primordiale: una mano che manipola della terra. Gli albori del fare. Eppure
non si sapeva per chi fossero questi oggetti e spesso configuro che fossero per questo
pubblico di invisibili per cui mi piaceva lavorare. Questo ricordo è significativo
anche nella pratica odierna perché in qualche modo è come se mi confrontassi
ancora con degli invisibili, sia nella produzione, sia come referenti. Immagino ancora
dei fruitori che non sono solo umani e visibili. Sia nella ricerca che nell'analisi, perché
spesso anche la mia materia è invisibile.
La materialità è diventato sia un materiale che un interlocutore.
MM:
Talvolta sembra che attui un meccanismo di difesa nei tuoi interventi, dove li difendi
dallo sguardo stesso? (Mi viene in mente per esempio Fanfani Nephews, ma anche
la modalità di presentare il tuo lavoro attraverso la voce di altri senza mostrarlo
direttamente)
NR:
Lo sguardo può essere pericoloso. I lavori, quando vengono esportati, diventano oggetti disanimati. E’ importante difendere sia chi guarda che chi è guardato. L'intenzione è
di preservare queste opere da un contesto che sa essere vampirizzante. Un contesto che ha delle dinamiche non sempre sane, limpide.
Fanfani Nephews è stato all'interno di una call che aveva fatto Dior verso giovani artisti
Di Brera. La borsa Lady Dior era l'oggetto che doveva essere all'interno delle
varie opere. Nel mio caso ho deciso di contendere la borsa tra le mie due sorelle che
vivono in una casa popolare in Piemonte con mia madre. La cosa è finita male, si sono davvero azzuffate per avere la borsa. Così ho deciso di censurare il progetto e proporre un'altra
opera “normalizzante”.
La fotografia per me è iniziata come difesa e strumento di analisi e comprensione
all'interno del mio nucleo, tra me e il familiare che familiare non lo era affatto.
Fanfani Nephews è stato censurato perché c'era stato un disequilibrio nella lavorazione,
non sapevo se regalare un'opera di questo tipo, anche se probabilmente avrebbe
funzionato bene. La censura è stata per proteggere la storia, in quel caso non mi sembrava il contesto giusto per esporla.
MM:
Un altro contesto dove decidi di negare la visibilità è proprio durante le
presentazioni del tuo lavoro in pubblico. Nessuna presentazione power point e
fotografie da visionare, ma registrazioni audio di altre persone che parlano del tuo
lavoro...
NR:
Quando presento i lavori attraverso le registrazioni, è perché in primis, detesto e non
sono capace di parlare in pubblico. Mi vengono degli attacchi di panico fulminanti e non
sono più lucida. Quindi nelle occasioni in cui mi è capitato di parlare al pubblico ho
dovuto trovare degli escamotages per presentarmi senza farlo io. In questo caso la
presentazione diventa anch'essa un'opera e quindi presenta delle problematiche legate alla performatività dell'operazione. Oltre alla spinta emotiva, c'è anche da parte mia un
non apprezzamento delle modalità canoniche di presentazione, che trovo curricolari,
autocelebrative e comunque parziali. Non immagini niente, è dis-erotizzante. Non stai
regalando niente, non c'è un'esperienza che facciamo insieme, non c'è un incontro. In
questo modo invece stai venendo a fruire qualcosa anche se non c'è, ti immagini delle opere che io non ho mai fatto. Entra nel lavoro anche uno sforzo di immaginazione del pubblico.
Attraverso parole non mie, l'opera assomiglia all'opera che l'artista ha fatto? É
interessante anche raccogliere descrizioni da parte di terzi, quindi raccogliere narrative
altre e poi, una volta esposte al pubblico, ci sono 50 opere diverse nella testa di 50
persone diverse.
MM:
Quindi non mostravi proprio nessuna immagine?
NR:
Nulla, era una sessione di ascolto.
MM:
Perchè vuoi complicare la fruizione del tuo lavoro?
NR:
Non voglio complicare la fruizione ma sicuramente nemmeno facilitare o accomodare. Visto che le realtà sono complesse e stratificate e che per nessuno è facile fare, comprendere e avvicinarsi alla fatica è un valore di scoperta che non voglio semplificare. Penso che il pubblico si possa responsabilizzare e non infantilizzare o addormentare. Poi facendo vedere una sfilza di fotografie in un portfolio mi sembra di mostrare una festa in cui il pubblico non era invitato, a cui non hanno partecipato. Così invece c'è un'esperienza nuova di corpi. Stiamo tutti zitti e può portare disagio se è il disagio che hai, o la rabbia. Per ascoltare in gruppo bisogna essere molto concentrati, è necessario fare molta attenzione, essere presenti. Il tuo corpo inizia a prendere importanza. In quei momenti si crea una tensione strana, un po' disarmante, ma non solo. Può essere anche molto bello, seppur sia capitato che presentare questi audio abbia creato dei forti dibattiti e ci siano state delle reazioni consistenti.
MM:
E come mai attraverso le voci degli altri e non la tua?
NR:
Non credo che il mio filtro sia più importante di quello di altri. Forse da un lato mi deresponsabilizzo, ma dall'altro mi chiedo, sono così importante ?
Le opere sono vive. Perché dovrei imbrigliare il pubblico nella mia unica narrazione ? Se devo imbrigliare nelle parole, almeno che lo si faccia insieme.
Quello che penso è: “vediamo se siete d'accordo con quello che dirà qualcuna di queste
voci.”
Le opere alla fine sono degli strumenti, non dei punti di approdo, per quanto poi lo diventino
quando vanno a morire nei musei. Sono delle armi che si possono anche usare contro se stessi o contro dei sistemi, dei blocchi sociali. Non abbiamo tutte queste esigenze visive, ma l’immaginario può essere stimolato anche solo con una minima sollecitazione o evocazione sottile. E questa evocazione di fantasmi ha anche l'intenzione di ironizzare e non prendere sempre troppo sul serio i nostri playground, la mia ricerca o quella degli altri. In fondo siamo tutti fedeli a una qualche narrazione e come falene che vedono laggiù la luce, ci buttiamo a capofitto bruciandoci.
MM:
Riguardo alla ironizzazione e demistificazione del linguaggio e ruolo dell'artista mi
viene in mente anche Il Palco è Vuoto.
NR:
Mi sono resa conto che i linguaggi dell'arte contemporanea, come tutti i campi disciplinari, ti offrono degli strumenti che sono anche dei tricks. Il bon ton dell'arte si manifesta in una veste intellettuale e linguistica specifica. Oltre ad un'egemonia del sapere c'è anche un'egemonia del linguaggio. Se ci togliessimo dai nostri ruoli di artisti, curatori o addetti ai lavori e ci ascoltassimo, ci pregheremmo di scendere dal palco e utilizzare un linguaggio meno artificioso. È chiaro che ogni disciplina ha una sua linguistica preferenziale, e quello dell'arte è un pot-pourri interdisciplinare. A volte però il linguaggio egemonico è una protezione.
Quando c'è tanto fumo di referenze, citazioni ed estetica, vuol dire che manca qualcosa, forse di meno nominabile. Il palco è vuoto, è stata una performance alla quale ho lavorato con un logopedista, collezionando le parole ricorrenti dei testi critici di alcune esposizioni.
Le abbiamo poi fatte ripetere allo sfinimento al pubblico, trasformandole in parole senza significato.
Giusto per esasperare questo uso delle parole, così magari un giorno le usiamo con più coscienza oppure non le usiamo perché non ci appartengono, o ne inventiamo di nuove.
MM:
Che ruolo dovrebbe avere il luogo dell'arte nel nostro momento storico?
NR:
Secondo me ci devono essere dei luoghi anche pesanti.
Dei luoghi, oggetti, atmosfere, che possano essere faticose, problematizzanti, critiche, che non ti fanno stare bene perché bene non ci stavi manco prima. Il luogo dell'arte non può essere un luogo solo di piacere, di comodità e di bellezza. Forse sarò antica ma la
bellezza per me deve essere anche etica. C'è qualcosa della bellezza che deve portare anche un dato di messa in discussione, di responsabilità.
Ho la percezione di vivere in un momento in cui siamo narcotizzati, e solo parzialmente curiosi perché assuefatti a tutto. Siamo così supportati di ogni comfort che i gadget delle nostre esistenze ci tolgono completamente l'autonomia.
MM:
Trovi che questo si rifletta anche nel pubblico che dell'arte fa esperienza?
NR:
C'è un'infantilizzazione del pubblico a cui si dà un giochino e questo se ne esce apparentemente felice e contento. Il pubblico viene sempre di più trattato senza autonomia e risorse. Dovrebbe invece essere diverso.
Non sono più sufficienti le opere che ci son state finora. È importante incontrarle perché
discutono del passato, del presente e anche del futuro, però Duchamp alla sua epoca non tranquilizzava nessuno ed è dovuto passare molto tempo perché forse oggi possa non perturbare più così tanto.
Anche se lavoro con la sparizione, lavoro con il niente, ora c'è un altro niente. E non posso essere comoda. Perché nessuno di noi può essere comodo con i propri contemporanei, mentre si sta mettendo in discussione il paradigma del presente con i problemi in esso racchiusi.
MM:
Pensi sia possibile continuare a ricercare e portare avanti la propria pratica quando
c'è una difficoltà reale e concreta che non lascia spazio ad altro?
NR:
Se quest'arte si può avvicinare a dei disequilibri esistenti, a dei problemi sociali e politici,
senza retorica, sì. Anche l'arte è un oggetto problematizzante. Certo, poi magari viene
mistificato e perde forza, ma ci sono momenti dell'opera che hanno una grandissima
aderenza alla realtà. Quando c'è questa aderenza, non è più importante la differenza tra lavoro, vita, pratica. Diventa uno strumento di sopravvivenza per la vita (di merda) di tutti
noi, meno o più. Le opere possono rivelarsi delle astronavi, degli escamotages
per riunirci.
L'incontro è una conquista.
Il motivo che mi ha mosso a fare delle cose è sempre stato una spinta alla sopravvivenza relazionale, psichica, creativa.
Lo sviluppo della comprensione delle cose rilevate nel reale è stato l'unico metodo per starci dentro, discutere, pensare, studiare, manipolare le nostre fragilità e farne altro. Forse non è essenziale mostrare tutto in modo pornografico ma piuttosto agire lentamente, in modo sottile, come una polvere che non vedi, che si poggia sui pori della pelle.
Forse l’essenziale potrebbe essere fare le cose con presenza e attenzione, magari a volte stando anche zitti.